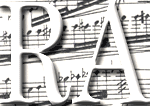 |
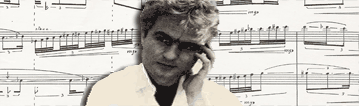 |
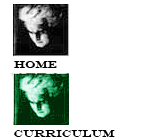
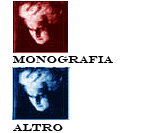
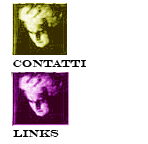
da “Linguaggi della musica contemporanea” a cura di Renzo Cresti, Ed. G. Miano, 1995
Rocco Abate si è formato alla scuola milanese, diplomandosi in Flauto, Strumentazione per banda e Composizione presso il Conservatorio "G.Verdi" di Milano, dove attualmente insegna flauto. Abbandonata nel 1978 l'attività concertistica - che l'ha visto impegnato, in Italia e all'estero, sia come solista, sia in complessi cameristici, nonchè in orchestre come La Scala, I Pomeriggi Musicali, la Sinfonica della RAI, la Sinfonica della Radio Svizzera, l'Angelicum, ecc. - si dedica da allora alla didattica e, principalmente, alla Composizione. Ha inoltre collaborato con numerose riviste musicali.
Il suo catalogo comprende opere per strumento solo, per complessi da camera, per voce, coro, strumenti elettroacustici, per orchestra. Programmate e radio-teletrasmesse in Italia, ma anche all'estero - Francia (anche Radio France), Germania, Spagna (anehe Radio Nazionale spagnola), Portogallo, Svizzera, Russia, Australia e Stati Uniti. Le sue composizioni, eseguite da interpreti di prestigio internazionale, sono edite da Edipan, Ricordi, Rugginenti. Alcune sono incise su dischi Edipan, Rusty Records, Fonit Cetra, Ricordi. Hanno parlato o scritto dcl suo lavoro, fra gli altri: P.Aequafredda, M.Bortolotto, F.Cella,Renzo Cresti, M. D'Amico, A Foletto, A. Gentilucci, G.Lozza, L. Ketoff, G. Negri, M.Pasi, L. Pestalozza, P. Petazzi, P. Renosto, G. Zàccaro.
ELOGIO DEL PUDORE
A un ampliamento della sfera comunicativa, Rocco Abate preferisce un andare in profondità, volutamente delimitando il raggio di comunicazione, scartando ogni orizzontalità dell'ascolto, per privilegiare esclusivamente la verticalità, la profondità dell'espressione, la qualità del rapporto, nella convinzione che l'unico sentiero percorribile sia quello che porta in direzione di noi stessi. L'impegno dell'artista rimane al di qua dei meccanismi produttivi, è rivolto allo scavo interiore, a portare alla luce le necessità spirituali più autentiche, mettendo così a disposizione degli altri la testimonianza del suo essere, testimonianza di persona, ben più sostanziosa di quella squisitamente intellettuale o di quella "sentimentale". Questi i propositi umani della musica di Abate, il quale coglie, con pudore, uno dei tratti fondamentali della cultura degli ultimi anni, quello della rivalutazione della persona, centro delle dinamiche sociali. Gran parte della cultura contemporanea è rimasta legata a letture di tipo sociologico, non cogliendo o non riuscendo a mettere in circolo la richiesta di una nuova dignità reclamata dalla testimonianza dell'uomo, inteso quale unicurm.
Nato a Oriolo, Rocco Abate si è trasferito a Milano per gli studi e nel capoluogo lombardo è rimasto. Non sappiamo quanto questa scelta sia stata proficua per l'uomo, prima ancora che per il musicista; qualche anno fa, nel nostro libro Verso il 2000 (1), esprimevamo delle perplessità sulla pacifica convivenza fra la generosa e profonda sensibilità di Abate e il manageriale e nevrotico ambiente milanese. Nella
musica del Maestro calabro é presente, prima esplicitamente poi come filo sotterraneo, uno struggente ricordo della natura natia, infatti nei pezzi giovanili vi si nota una straziante melodia e, a un tempo, una sorta di rabbia, una tensione continua che sembra riallacciarsi a mondi arcaici.
La forza della musica (ma ancor prima dell'uomo) di Abate sta nel mantenere intatta la sua squisita cultura e l'avvolgente tenerezza dell'intelletto (2).
Il raziocinio di Abate non é mai quello di una ragione solo ragionante, di un musicista "da lavagna'', come diceva Cocteau, ma sa modellarsi sulle esigenze del vissuto, andando incontro a quella tenerezza ch'è propria dell'intimità dell'essere di Rocco Abate, il quale scrivc: "L'intelligenza non fa il compositore \...\ si tratta di un'intelligenza speciale e che, proprio perché tale, è, forse, più esatto definire intuito, capacità di intuizione \...\ la bellezza è fatta di cquilibri delicati, di proporzioni che non si misurano, ma si intuiscono \...\ è forse il tempo di riparlare anche di quel misterioso oggetto che è la musicalità" (3). "Musicalità" è stata una parola proibita dai cerberi dell'ideologia della struttura, invece è un elemento essenziale alla buona riuscita del brano, difficile da delinire, ma chiarissimo all'ascolto; è dipeso proprio dalla mancanza di musicalità che la musica di stampo strutturalistico s'è allontanata dal pubblico, il quale (come nota anche Abatc nello scritto sopra citato) non è sordo e, forse inconsapevolmeute, si rende conto se l'opera che sta ascoltando nasce da veri stati di necessità oppure e solo un interessante giochetto sonoro; il pubblico ama farsi coinvolgere e se questo non è avvenuto è, in gran parte colpa degli stessi compositori (in questa sede lasciamo perdere lc deficenze della Scuola, dei Conservatori, delle Università, le colpe dei mezzi di comunicazione di massa ecc.). I neo-romantici, che pur si sono accorti del problema, hanno fallito perché hanno pensato a cosa fornire al pubblico di ben confezionato, effettuando una sorta di statistica sui gusti del pubblico, senza essere partecipi ad alcun perché e di questa inautenticità sentimentale il pubblico sè subito reso conto, percependo anche i furbeschi ritorni al passato e l'abbassamento della qualità della scrittura.
Per i canoni dell'impostazione meccanicistica, di tipo donatoniano, è un peccato far emergere la propria interiorità, la quale deve sottostare alle leggi del cosiddetto "materiale", anche quando queste conducono a zone di aridità, di ripetitività, di noia. In questi anni recenti molti compositori, escludendo le punte più ideologizzate, hanno sentito l'esigenza di ricercare soluzioni più vicine alla propria sensibililà, ovviamente non cadendo nel tranello di banalizzare il linguaggio, così Abate si ritrova in prima linea con le nuove esigenze critiche e metodologiche, al di qua di nei-strutturalismi, nei-romanticismi, nei-qualunquismi.
Nella musica di Abate l'argomentazione logica non è astratta, come a volte vorrebbe lo stesso Autore (4), ma piena di buon senso e la pratica speculativa conosce il dolce tepore della tenerezza. L'atteggiamento e(ste)tico di Abate è di pudore nei riguardi del pensiero teoretico, facendogli perdere quel carattere "forte" e "alto", aprendolo invece alle zone insicure, oscure, indicibi, deboli, una debolezza ch'è ricchczza e capacità di abitare se stessi e il mondo ''Abitare" non significa solo "capire" le cose, ma esserne affetto, per cui l'opera assume il valore della testimonianza. Da buon allievo di Donatoni, il meccanicistico tramutare del tessuto sonoro è stato per Abate il criterio su cui lavorare. ma l'indole e la natura mediterranea della sensibilità hanno mitigato, da sempre, anche inconsciamente, le asprezze di un meccanismo impersonale e prepotente. Da Abate ci viene una lezione di umiltà, salutare antidoto all'“inflazione dell'io” che, secondo Jung, è "la malattia del nostro secolo'', e una lezione di tolleranza che non è sopportazione, ma abbraccio sincero all'alterità dell' uomo, ch'è non è più altro, ma prossimo . La nostalgia dei profumi e dei cieli di Calabria è sottilmentc presente, visibile, a occhi attenti e amorevoli, dietro le griglie dei suoni. La tensione fra indole e rigore metodologico, fra la riottosità dei procedimenli e le esigenze espressive, questa tensione è stata, durante gli anni Ottanta, giocata sui nervi, mitigata dall'amorevolezza del gesto, una gestualità che diventa, via via, più personale e raccolta, più partecipata, soprattutto nei pezzi recenti, quando Abate mette a frutto l'aver capito che non era la soavità interiore, saremmo tentati di dire la grazia, a dover cambiare, ma ciò che doveva mutare era l'arcigno metodo compositivo, astruso e non adatto alla delicatezza del comunicare di un uomo amabile.
Flautista, scrive la sua prima opera, Sonatina del 1969, per il suo strumento. I tentativi giovanili si rifanno a Stravinskij, a Hindemith e a Bartok (del quale Abate conserverà un certo meccanicismo della scrittura, che ben si sposerà con l'insegnamento di Donatoni). Sulla metà degli anni Settanta, per esempio con Impromptus, il giovane Maestro inizia a formarsi una nuova consapevolezza linguistica, maturata filtrando il mondo fantastico di Castiglioni, il lirismo di Maderna, le esperienze di Varèse e alcune suggestioni pittoriche, da van Gogh a Munch, da Klimt a Ligabue, spesso filtrate altraverso il pensiero di Licini, della sua dialettica fra ragione e sentimento.
E' nel 1977 che si hanno i veri esordi compositivi, quando Abate inizia a lavorare su progetti più impegnativi, infatti in Sol'o il linguaggio diventa più sfaccettato, insistito su tecniche strumentali che portano i suoni al confine col rumore, linguaggio che si arricchisce di un'indagine sui suoni limitrofi. Ha inizio l'auto-imposizione della scelta di una regola e della vigilanza del rispetto di tale regola, anche se ampie zone sono dominate da una sgomenta volontà espressiva che provoca smagliature nella rete intervallare. I.'anno seguente, 1978, Abate scrive cinque pezzi brevi per pianoforte, intitolati Scripta Sonant dal carattere meditativo, seppur con scatti accordali eccitati e passaggi ritmici agitati, che non compromettano la stesura netta e severa.
L'originale e aleatoria partitura di Tatà Requiem (1981), composta dopo la morte del padre (Tatà, come lo chiamava Rocco), scritta per doppio quintetto di fiati perché ''l'oscuro gioco del tempo'' (come recita il sottotitolo) fosse sottolineato da una serie di accorgimenti: il primo quintetto sta vicino al pubblico, mentre l'altro si sistema in fondo al palcoscenico; al primo viene affidato un materiale cromatico e veemente, mentre al secondo un materiale formato da quarte e quinte luminose, figure lente e andamento corale. I due quintetti s'impastano con cautela, propone un tessuto strappato da suoni acutissimi, come un grido doloroso e tristissimo (dalla metà del brano fino al termine, la scrittura si fa più frastagliata c nervosa, fin ossessiva, romantik, forsc memorc di certi trattamenti alla Berlioz).
Knecht è il primo lavoro di Abate con scrittura di tipo automantico, l'unico parametro che sfugge a questo meccanismo sono le dinamiche, tutto il resto sottostà a un impianto numerico pre-determinato. Scritto nel 1982, il pezzo è un tormentato trio, specchio inconscio di una persona che, dietro la gentilezza dei modi e d'animo, è alla ricerca di un suo equilibrio: linee nervose del violoncello e del clarinetto si accavallano su accordi tesi, ma quest'opera risente di un certo gusto per l'affresco, al quale sfugge Nacht (dello stesso anno), dove la voce è lasciata nuda e si mostra in una vocalità ricca di inflessioni e agile, libera sul vuoto.
Dust, ancora del 1982, porta il significativo sottotitolo di "op. n. zero", volendo evidenziare una concentrazione assoluta, prima sconosciuta, su certe modalità di trasformazione incessante del materiale di partenza (5). La pratica della rilettura, il ripercorrere ossessivamente perentori itinerari è la disciplina con la quale Abate vuole forgiare il costrutto; segue questa tipologia di stesura anche il bel quartetto Tropie ( 1983), dove l'intrecciarsi delle voci è polivalente e non sistematico, superando una ccrta rigidità nella disposizione dei panelli compositivi. L'atmosfera espressiva, anche se controllata da una studiata polifonia (assai più evidente che nei brani d'esordio), rimanc viva, tesa e nervosa. La produzione si avvia alla maturità e preannuncia prove che lasceranno il segno, infatti nelle opere seguenti Abate rafforza la sostanza della scrittura, la quale approda a una grande intensità linguistica ed emotiva, si ascoltino le brevi, ma tesissime Cinque brevi variazioni su "là ci darem la mano" (1984) per ottavino e clarinetto basso, dove il linguaggio mozartiano si sbriciola, si frammenta, si prosciuga eppoi si ricompatta con assoluta originalità, in un gioco caleidoscopico di frammenti. Il brano si basa su una serie di undici suoni, ovvero mancante del FA; nelle cinque brevi variazioni, che partano da altrettanti frammenti del tema originale, l'inserimento del FA ha la funzione di bloccare il meccanismo della trasformazione del materiale, realizzando gesti fugaci. La tecnica della scomposizione e della ri-composizione cellulare sta alla base anche di Spira (con testo sulla droga, lavoro dell'89), qui un'asciutta polifonia coagula scheggie impazzite, la ricerca strumentale è in evidenza, giocata, con eleganza e scioltezza, su un flauto che dev'essere amplificato con riverbero c comprendente anche un testo (ad libitum) di Antonietta Dell'Arte.
Fra solve e congala gioca sempre la scrittura di questo Autore che crede nella forza del pensiero, della ricerca, al di qua di ogni banalizzazione sentimental-commerciale, ma che sa anche concedersi, partecipando all'atto costruttivo con tutto l'essere. Il frammento non è il risultato di un'estetica negativa, ma é carico di vissuto, che, con pudore, si ritrae dall'idealismo dell'unità e dall' inciviltà del troppo della società consumistica, per farsi testimonianza di esperienze minuscole che sopravvivono nell'ipertrofia dell'(in)civiltà di massa. Come il Palomar di Calvino, Abate compie piccole esperienze, vere proprio in quanto minute.
L'oggctto che Abate sceglie viene osservato, con spostamcnti repentini, da più punti di vista: l'oggetto rimane sempre lo stesso e quel ch'è straordinario è che assume forme talmente diverse da rendersi irriconoscibile. Caratteristiche tecniche costanti sono la discontinuità degli sviluppi e la successione contrastante delle sezioni, le quali soltintendono una sorta di drammaturgia, un teatro della mente.
La forma è il finito di una progettualità compositiva che si realizza nel confronto fra intuizione, ragione e necessità. Senza una vera necessità interiore la scrittura è mero calligrafismo. Le Sei bagatelle (1985) per trio d'archi sono, come tutti i brani di questo periodo, basate su una griglia strutturale nella quale la sedimentazione delle linee fa “tralucere un sostrato tematico-motivico ove la citazione, mai nostalgica, è assunta a lettera morta \...\ esaurita una lectio possibile dell'oggetto assunto a figura, questo viene abbandonato in tutta la sua interezza depassée, non più fungibile e per ciò stesso non più fruibile'' (Carlo Alessandro Landini). La "minuziosa precisione di scrittura", come ebbe a dire Paolo Renosto, dimostra ''una tensione all'interiorizzare del pensiero compositivo", realizzata grazie a una straordinaria attenzione nei confronti del suono, attenzione non solo in senso tecnico-artigianale (la partitura presenta anche delle notevoli difficoltà strumentali), ma soprattutto in senso emotivo, volgendosi al suono amorevolmente.
Soluzioni esecutive specifiche si riscontrano nel formicolante pezzo per clarinetto. Trista o degli oggetti, composto nel 1986, come anche Eco per due ottavini, brano interessante dal punto di vista ritmico e dinamico; un'aleatorietà controllata sta alla base di Voci (1987) per quattro chitarre, pezzo che gioca pure su una disposizione spaziale degli elementi sonori, realizzando una pagina graficamente bella a vedersi e ricca di idee strumentali. Simile è l'impostazione del brano per oboe amplificato, con eco e riverbero, intitolato significativamente Narciso (1990). infatti i gesti si fanno più espliciti rispetto a quelli raccolti di Spira che, semmai, da un punto di vista espressivo si riallaccia a lavori ai limiti del silenzio, come il coro Nulla e vento (1987), dove i soffi danno la sensazione del vento e il canto si presenta in un'impalpabile inconsistenza di suono, eppure da questo vuoto apparente esce una cantabilità coinvolgente, diafana ma preziosa, che sorge da mondi lontani e a questi ritorna (l'inconscio?).
Sul concetto di cantabilità Abate non è d'accordo, per lui quando si notano figure in evidenza è perché non è perfettamente riuscita la compatta costruzione dei meccanismi che regolano il tessuto sonoro: che sia allora un bisogno del materiale stesso, quello di uscire cantando'' Al di là della volontà di chi lo ha impostato? Abate crede che questa voglia di canto sia leggibile come "errore" o come "caduta di gusto", ma è il suo pudore che non vuole concedersi a momenti troppo espliciti.
I brani composti fra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta, conservano il rigore della scrittura, a cui Abate non saprebbe mai rinunciare, però marcano in maniera più pronunciata l'aspetto emotivo, vediamo quali sono: Spettri per fagotto e pianoforte, composto nel 1987; il grande lavoro dell'anno successivo, Nell'occhio, la memoria per orchestra; lo svolazzante Vocabol'involiera (1990) per flauto o ottavino e pianoforte; il brano per voce recitante, violoncello e sintetizzatore, che dimostra la crescente attenzione per i rapporti fra letteratura e musica, brano composto nel 1990, intitolato Ben disposti silenzi e basato su un testo di Zanzotto; altri lavori che utilizzano dei testi sono Bestiario, per voce recitante e nastro magnetico su testo di Lubrano e In un sogno ventoso (scritto, come il precedente, nel 1990) per soprano, voce recitante e nastro magnetico su testo di Angelini, pezzi da camera che fanno da viatico alla stesura dell'opera teatrale. In questi brani le linee orizzontali si dispongono in blocchi, in aggregati sonori più o meno condensati; sono masse che si scontrano creando pieni e vuoti nello spazio e luci e ombre nei colori. Da notare che dal 1988 al 1990, in questi due anni Abate scrive solo Spira, ma si costruisce una sorta di serbatoio di idee che utilizzerà in seguito, quando, dal '90 in poi, la sua attività riprende a cadenze regolari (e comunque mai frenetiche). Altri lavori almeno da ricordare sono: :Trama (1990) per 10 flauti, che parte da un accordo in fortissimo per poi disporsi in un'articolata fascia sonora, inoltre Chronos et Mnemosyne (ancora del '90) per quintetto d'archi e tre fiati, ovvero per un ottetto che ha lo stesso organico di quello di Schubert e che prende vita proprio dalla prima nota, un FA, del lavoro del Maestro di Vienna, instaurando procedimenti di elaborazione chc si dispongono in uno spazio dilatato, realizzando un disinvolto ed elegante sviluppo, senza riferimenti diretti a stilemi della musica schubertiana o romantica. Oltre al nastro magnetico, mai utilizzato prima, Abate continua a far ricorso, in questi anni, alla prassi di amplificare uno strumento con un poco di riverbero, creando sonorità particolari, come nel caso di Sublimen (1990) per clarinetto con un testo ad libitum (com'era avvenulo in Spira ) della Maraini; in questo lavoro Abate crea un labirinto musicale che si rivela una trappola: Dedalo ha smarrito la strada, corre lungo pareti di specchi, ha perduto la sua identità. Proprio nel gioco della presenza\assenza della musica, come della condizione psicologica e mentale, il pezzo esprime il suo fascino.
Alla musica da camera, per la sua stessa natura raccolta e meditativa, che permette un prezioso dispiegarsi della parti, Abate è particolarmente legato e questa musica gli si confà pienamente, esaltandone sia le doti di abilità nell'articolare il costrutto, sia le capacità espressive: si ascolti il bel lavoro, per violoncello e pianoforte amplificati, con eco e riverbero, dal titolo Antica (1993) dove la compatezza della forma e la severilà del linguaggio, si sposano con una struggente voglia di canto, realizzando un brano vigoroso e affascinante. L' esaltazione delle virtualità del suono, inteso come emanazione di un bisogno interiore, si riscontra pure nel R.E.Q.U.I.E.M. per orchestra, nel quale l'articolazione rigorosa del materiale, le varie letture di micro-cellule che si aprono a raggiera, la ricerca di relazioni nascoste fra gli elementi, lasciano comunque spazio a un gesto emozionale. In questi anni (dall'89 a oggi) Abate recupera una scrittura più libera e a tinte emotive, che era tipica dei primi lavori (fino all'82), arrivando a una conciliazione fra rigore di scrittura e comunicatività. E' il concetto di gioco che sta alla base del linguaggio: Abate sceglie la sua regola e su quella costruisce le articolazioni, non c'è gioco senza regole e queste sono assolutamente autonome, valgono solo perché scelte quale presupposto.
Il Requiem viene scritto nel 1992, lo stesso anno in cui compone le pagine sinfoniche da "Dottor Sincretico". Abate sta lavorando a un'opera teatrale (da cui ha già tratto le citate Pagine sinfoniche e il bel quintetto d'archi intitolato Progetto Sincretico ) su libretto di Rruno Pedretti, dal titolo Dottor Sincretico lavoro che, ne siamo sicuri da quello che conosciamo, sancirà un approdo definitivo alla felicità della musica, attraverso una ragione mansueta, domestica, finalmente attenuando l'oppressione del metodo meccanicistico, finalmente cantando (il canio come errore necessario?), scoprendo, come Abate ha già fatto nelle partiture migliori, la tenerezza della ragione. Il Dottor Sincretico è un magisirato che vuole presentare sua figlia Veronica ai tre linguaggi del mondo, che sono rappresentati dal poeta Fausto, dal narratore Epifanio e dal drammaturgo Poligeno. Sincretico, geloso della figlia, intenta un processo per reato di plagio ai tre artisti, condannandoli a una morte simbolica. Analogo destino tocca a Veronica. Sincretico, che ha fagocitato tutto, morirà per "troppa perfezione", infatti l'opera finisce col protagonista che, delirante, si trasforma in un cristallo nero. Il lavoro è ricco di sfaccettature e di simbologie, musicalmente Abate condensa la sincreticità in un cluster, dal quale si diramano tese traiettorie o sequenze o temi che riguardano i vari personaggi, i quali, attraverso questi accadimenti sonori, mimano una microdrammaturgia teatrale. "Abate parte da un'idea totalizzante del suono generatore (il cluster: più che altro metafora d'una entità sonora che non possiede una sola direzione, ma si presta a essere osservata nello spazio) \...\ i suggerimenti del cluster d'avvio sfilano variegati e netti, Fino a esaurirsi in una sorta di decompressione timbrica che conduce alla dissolvenza conclusiva" (ó). Il parossismo di alcune sezioni (anche con citazioni dal Guglielmo Tell di Rossini, assolutamente non funzionali al discorso e quindi creanti, proprio perché decontestualizzate, un clima irreale e metafisico), l'aggrovigliarsi degli elementi conduce a una sostanzialc con-fusione, riproponendo le condizioni musicali per la cristallizzazione del cluster iniziale, che dal forte sparisce nel nulla, e nel vuoto, come un buco nero, un rantolo implosivo di Sincretico divora gli ultimi istanti di silenzio.
L'esperienza estetica inizia quando viene sospesa la coditicata comprensione del mondo, allora, liberata dalla costrizione di mantenersi conforme alle regole, la mente viene stimolata a riflessioni libere. L'esperienza estetica si compie, al di là dell'oggettività e dell'indifferenza che Abate stesso spesso propugna (rifacendosi a Duchamp), quando riusciamo a vedere nelle cose un quid particolare, quando sappiamo coglierne un di più: "l'uomo cerca l'esonero. L'esonero si ottiene nella forma di un residuo che non può essere corrotto dai funzionalismi, dove tutto è così come è in se stesso \...\ l'esperienza estetica, sullo sfondo delle complesse funzioni della quotidianità, consiste in una perfetta assenza di funzioni" (7). Se quindi, dando per scontato l'artigianato, occorre trovare spazi nuovi per l'espressione artistica, la produzione recente di Abate ci sta provando, riattivando l'intuizione poetante che non sta in antitesi al ragionamento e alla tecnica, ma ne e complementare , anzi l'intuizione prolunga le prassi rigorose della composizione, scartandone però le rigidezze di procedimenti meccanici e i rischi dei processi codificati, rendendo più flessibili e induigenti le articolazioni del pensiero compositivo, più disponibili ad accogliere le movenze dell' espressività, mantenendo sempre vigile la razionalità, ma con pudore.
NOTE
I ) Cfr. R. Cresti, Verso il 2000, edizioni il Grandevetro, Pisa 1990. Racconta Abate del suo arrivo a Milano: "quando, con i miei calzoni corti, affronto lo scalone del Conservatorio e vedo in alto l'incombente quadro con un accigliato Beethoven, mi spavento. La città nuova, il mito del Conservatorio. Avevo anche problemi di comunicazione. Parlavo un italiano misto al dialetto, ma cominciai presto a legare con i miei compagni" (Vita da musicista intervista di Paolo Lezziero a Rocco Abate, in "Nuova Sesto", 5 giugno 1993). La schieltezza e la nobiltà d'animo, tanto vicine alla genuinità "contadina" quanto lontane dalla freddezza metropolitana, sono state, durante gli anni Ottanta, delle caratteristiche che hanno dovuto modellarsi su atteggiamenti e linguaggi codificati, su quella cultura musicalc sostenuta dall'Apparato che avrebbe dovuto garantire al giovane Maestro l'inserimento nel mondo ufficiale della musica colta. Dell'inganno ottico (in senso ermeneutico), del bluff costituito dalle false lusinghe delle Istituzioni, Abate se n'è accono in ritardo, ma se n'è accorto.
2) Cfr. R. Cresti, Rocco Abate, la tenerezza dell'intelletto, nella Rivista "Il Pasquino musicale", anno II n 2, Latina 1992. Articolo utilizzalo anche nel dèpliant pubblicitario, sulla produzione di Rocco Abate, da Rugginenti editore in Milano.
3) R. Abate, Il Compositore? Mandiamogli un avviso di garanzia , Rugginenti, Milano 1994. Il titolo curioso deriva dal clima di Tangentopoli, anche i compositori, dice Abate, hanno
grandi responsabilità nei rapporti sociali, forse non hanno commesso ladrerie come i politici, ma si sono macchiati della colpa di presunzione, nel caso di quei compositori che si sono chiusi nella torre d'avorio, o di qualunquismo, nel caso di quelli Autori che hanno svenduto le loro operine ben fatte al mercatino del bric e brac. Scrive Abate: " i compositori intelligenti \...\ la loro attività, così scientifica e così poco umana \...\ l'avanguardia è un ciclico processo catartico \...\ un salutare stato febbrile ch'è tanto più benefico quanto più è rapido nel suo apparire, agire e dileguarsi \...\ il cosidetto neo-romanticismo (mai tanto impropriamente fu denominata una corrente artistica che meglio sarebhe chiamare neo-banalismo) \...\ non fu l'auspicato "nuovo capitolo'', ma un frutto malato, nato dall'albero della tradizione severa, un equivoco pretesto, emerso dalle ceneri di uno strutturalismo ipertrofico e agonizzante: la classica risposta sbagliata a un problema reale".
4) R. Abate, in una dichiarazione a "Musica Viva", n. 4, Milano, aprile 19g0: "impadronirmi del linguaggio ha significato, per me, un impegno testardo di volontà, essendo io proveniente da quel sud disgregato il cui fatto culturale, là dove esiste, non tiene il passo con i tempi".
5) In quegli anni, così ci scriveva Abate: "vorrei superare una certa rigidità (spesso presente nella divisione in sezioni delle composizioni. Questo superamento mi sembra che sia parzialmente avvenuto in Dust, dove le prime tre note continuamente trasfonnate (dilatazioni, frantumazioni ecc.) danno origine a una griglia (struttura portante dell'intero brano) che insieme col carattere unitario della composizione consente anche una maggiore gradualità di transito fra le sezioni. Il proposito intorno al quale vado lavorando da qualche tempo è appunto quello di radicalizzare questi procedimenti e di estenderli alle varie parti strumentali che pur partendo da materiale comune dovrebbero diversificarsi via via".
6) A. Foletto, Angelicum, in "La Repubblica" del 16 aprile 1992.
7) R. Bubner, Esperienza estetica, Rosenberg & Sellier, Torino 1992. pag. 165.
COMPOSIZIONI
Sonatina, per flaulo e pianoforte, 1979.
La Recherche, per flauto, violino, viola, violoncello e oboe, (fuori scena), 1970.
Soledad, per orchestra d'archi e percussione, 1975.
Improptus, per flauto e pianoforte, 1975.
Sol'o, per flauto, clarinetto basso, pianoforte, percussioni, violino, viola e violoncello, 1978, Edipan.
Scripta Sonant, cinque pezzi brevi per pianoforte, 1978, Edipan.
Sol'o, per orchestra, 1980, Rugginenti.
Tatà Requiem, per doppio quintetto di fiati, 1981, Edipan.
Knecht, per clavicembalo, violoncollo e pianoforte, 1982, Rugginenti.
Nacht, per voce femminile, su testo di Georg Trakl, 1982, Edipan.
Dust op. 0, per ottavino, 1982, Rugginenti.
Tropie op. 01, per quartetto d'archi, 1983, Edipan.
Sei bagatelle op. 02-5, per violino, viola e violoncello, 1984-85, Ricordi.
Cinque brevi variazioni op. 03, su "là ci darem la mano", per ottavino e clarinetto basso, 1984, Ricordi.
Four Piano Time, opera 06, per pianoforte, 1985, Edipan.
Eco op.O7, per due ottavini, 1986.
Trista o degli oggetti op. 08, per clarinetto, 1986, Ricordi.
Zois per voce maschile, su testo di Rocco Abate, 1986.
Timscel op. 09, per soprano e clarinetto, 1985.
Voci op. 012, per quattro chitarre, 1987.
Nulla e vento op. 011, per coro misto a cappella, su testo di Rocco Abate, 1987.
Spettri op. 013, per fagotto e pianoforte. 1987.
Nell'occhio la memoria op. 014 per grande orchestra, 86-88
Vocabol involiera op. OIS, per flauto o ottavino e pianoforte, 1990. Ricordi.
Ben disposti silenzi op. 017 per violoncello, Sint. e voce recitante, su testo di A. Zanzotto, 1990.
Spira op. 019 per flauto ampl. e con poco riverbero, su testo (ad libitum) di A. Dell'Arte, 1989, Ricordi.
Chronos e Mnemosyne op. 021. per clarinetto, corno, fagotto, due violini, viola, violoncello e contrabasso, 1990, Ricordi.
Narciso op.O22 per oboe ampl. e con poco riverbero, 1990, Ricordi.
Meta appunti per il dott. Sincretico op. 023, per baritono, voce recitante e nas.magn.,su testo di B.Pedretti, 1990.
Bestiario per voce recitante e nas. magn, su testi di C.Lubrano, 1990.
In un sogno ventoso op. 024 per soprano, voce recitante e nas. magn., su testo di Claudio Angelini, 1990.
Sublimen op. 026, per clarinetto amplificato e con poco riverbero, su testo (ad libitum) di Dacia Maraini, 1990.
Pagine Sinfoniche da Dottor Sincretico op. 027 per orchestra, 1992, Ricordi.
R.E.Q.U.I.E.M. op. 028 per orchcstra, 1992, Rugginenti Estratto op. 029 per fagotto, 1992.
Progetto Sincretico op. 030 per quintetto d'archi o orchestra d'archi, 1993, Ricordi.
Evelina op. 031 per flauti, 1993.
Angelica op. 013-032 per violoncello e pianoforte amplificati e con eco riverbero, 1993.
Voce per soprano, flauto e pianoforte. su testo di Alessandro Miano, 1995.
Discografia:
-Tropie in LP Edipan, PAN PRC S20-42;
-Sol'o. in LP Edipan, PAN PRC S20-37;
-Scripta sonant; Four Piano Time in CD Edipan;
-Progetto sincretico op. 030 in CD Fonit Cetra/Ricordi;
-Brani vari in CD Rusty Records
[HOME] [CURRICULUM] [MONOGRAFIA] [ALTRO] [CONTATTI] [ LINKS ]


